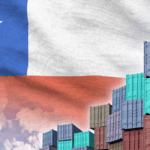Gli Incoterms sono regole standard elaborate dalla International Chamber of Commerce (ICC) che chiariscono, in modo uniforme a livello internazionale, i ruoli, le responsabilità e il passaggio del rischio in una compravendita di merci. Nascono nel 1936 e, da allora, vengono aggiornati periodicamente per riflettere le pratiche del commercio globale. Non sono leggi ma vengono riconosciuti e impiegati dalle imprese, dalle autorità e da organismi come UNCITRAL come riferimento globale per interpretare i termini commerciali più usati.
Ciononostante, nel panorama del commercio internazionale, le sigle degli Incoterms rappresentano spesso un ostacolo tecnico e linguistico. Per chi lavora nella logistica o nella gestione delle vendite estere, familiarizzare con queste clausole è assolutamente essenziale. Tra tutte, parleremo in particolare del CIF e chiariremo di cosa si tratta partendo dal contesto attuale e arrivando a capire quando e perché ha senso scegliere proprio questa modalità di resa.
Incoterms 2025: ci sono novità?
Chi si aspetta grandi rivoluzioni negli Incoterms per il 2025 potrebbe rimanere deluso. L’ultima edizione ufficiale, infatti, resta quella pubblicata dalla Camera di Commercio Internazionale nel 2020, ancora perfettamente valida. Le revisioni, invece, storicamente arrivano circa ogni dieci anni: il prossimo aggiornamento strutturale, quindi, è atteso intorno al 2030.
Tuttavia, il contesto in cui queste regole si applicano è in continua trasformazione, e questo non è un dettaglio da sottovalutare.
Nel corso degli ultimi anni, infatti, sono emersi alcuni aspetti che meritano attenzione. Le variazioni nei dazi doganali, le restrizioni normative nazionali e le mutate condizioni assicurative rendono necessaria un’applicazione più consapevole degli Incoterms. Per esempio, in alcuni Paesi è richiesto per legge che l’assicurazione venga stipulata esclusivamente con compagnie locali, oppure è vietato che lo sdoganamento venga curato da soggetti esteri. Di conseguenza, pur non essendoci modifiche nel testo ufficiale, è il modo in cui questi Incoterms vengono adottati che cambia, anche sensibilmente.
In altre parole, non è il documento che evolve, ma l’ambiente in cui lo si utilizza. E questo, per chi opera nella logistica, è un fattore che può fare la differenza tra una spedizione lineare e un contrattempo spiacevole.
Quanti Incoterms ci sono nel 2025?
Anche su questo punto la situazione è piuttosto stabile. Gli Incoterms attualmente in vigore sono undici, come previsti dalla versione 2020. La distinzione più importante da tenere a mente riguarda la modalità di trasporto. Alcuni Incoterms, come CIF o FOB, sono riservati esclusivamente al trasporto via mare o acque interne. Altri, come DDP o DAP, sono pensati per qualsiasi modalità di trasporto, incluse quelle multimodali, ossia quelle che combinano strada, ferrovia, aereo o container.
Va ricordato che, rispetto alla versione precedente, l’Incoterm DAT è stato sostituito da DPU, che significa “Delivered at Place Unloaded”, ovvero “reso scaricato nel luogo di destinazione”. Non è un cambiamento da poco: il venditore, in questo caso, ha l’onere di organizzare anche lo scarico della merce, e non solo il trasporto.
Piccolo inciso: In ogni contratto commerciale è sempre fondamentale indicare in modo esplicito la versione dell’Incoterm di riferimento. Non basta scrivere, ad esempio, “CIF Rotterdam”, è necessario aggiungere anche “Incoterms® 2020” per evitare equivoci, soprattutto in caso di dispute legali. Una svista su questo fronte può avere conseguenze ben più gravi di quanto si possa immaginare.
Cos’è il CIF? Per cosa si usa?
Il CIF, acronimo di “Cost, Insurance and Freight”, è una clausola pensata per le spedizioni marittime. Non si applica dunque a trasporti terrestri, aerei o multimodali. La sua logica è piuttosto semplice: il venditore si assume l’onere di organizzare e pagare il trasporto fino al porto di destinazione, oltre a stipulare un’assicurazione sulla merce. Tuttavia, e qui sta l’equivoco più comune, il rischio legato alla merce non resta in capo al venditore fino all’arrivo nel porto finale. Al contrario, il rischio si trasferisce all’acquirente nel momento esatto in cui la merce viene caricata a bordo della nave, nel porto di partenza.
Questo significa che, anche se il venditore ha pagato il trasporto e l’assicurazione, eventuali danni o perdite occorse dopo il caricamento sulla nave ricadono comunque sull’acquirente. L’assicurazione, infatti, è una copertura minima, pensata per limitare le perdite, non per annullarle del tutto.
Il CIF è quindi una formula che può tornare utile in diversi casi. Ad esempio, quando il venditore ha una posizione di forza nella contrattazione con i trasportatori marittimi e riesce a ottenere tariffe più convenienti. Oppure quando l’acquirente, pur accettando il trasferimento del rischio, preferisce non occuparsi della logistica fino al porto di arrivo. In alcuni mercati, questa clausola è praticamente uno standard, specie nel commercio di materie prime o prodotti non deperibili.
Differenza tra CIF, DAP e DDP
A prima vista, CIF, DAP e DDP possono sembrare clausole simili: in fondo, in tutti e tre i casi il venditore si occupa in parte o totalmente della spedizione. Ma a ben guardare, le differenze sono sostanziali.
Nel caso del CIF, come abbiamo visto, l’impegno del venditore si ferma al porto di destinazione, e il rischio passa al compratore non appena la merce è stata caricata sulla nave. DAP, invece, prevede che il venditore consegni la merce nel luogo concordato, pronta per essere scaricata. Non è responsabile dello scarico, ma accompagna la merce fino alla soglia, per così dire, del compratore.
Con DDP, la responsabilità si spinge ancora oltre. Il venditore si prende carico non solo del trasporto fino alla destinazione finale, ma anche di tutti i costi e le formalità doganali. È lui a pagare dazi, IVA, e a curare lo sdoganamento. Per l’acquirente, questa è la formula più comoda in assoluto, perché riceve la merce “chiavi in mano”, senza doversi occupare di nulla.
Tuttavia, proprio per questo motivo, DDP è anche la clausola più onerosa per il venditore, e non sempre applicabile. In alcuni paesi, ad esempio, le normative impediscono a soggetti esteri di effettuare lo sdoganamento. In questi casi, utilizzare DDP può generare complicazioni legali non da poco.
CIF, quindi, si colloca in una posizione intermedia: il venditore fa molto, ma non tutto, e il compratore deve comunque essere pronto a gestire i passaggi successivi all’arrivo della nave.
Quale Incoterm conviene scegliere nel 2025?
La risposta è molto semplice: l’Incoterm “migliore” in assoluto non esiste. La scelta, infatti, va fatta in base al contesto: tipo di merce, rotte coinvolte, vincoli doganali, copertura assicurativa, capacità operativa delle parti. Ogni clausola distribuisce in modo diverso rischi, responsabilità e costi lungo la catena logistica, e proprio per questo va valutata come uno strumento strategico, non come una semplice formula contrattuale.
Occorre chiedersi quanto controllo si vuole mantenere sul flusso operativo, che tipo di visibilità si richiede sulla spedizione e se si dispone o meno delle risorse necessarie per gestire gli adempimenti locali. Oltretutto, è fondamentale che l’Incoterm si integri bene con il resto del contratto: termini di pagamento, documentazione, obblighi assicurativi, normative internazionali. Non dimentichiamoci che gli Incoterms non definiscono il passaggio di proprietà né coprono tutti gli aspetti fiscali e doganali. Vanno scelti con attenzione, ma anche affiancati da una struttura contrattuale coerente.
Nel prossimo futuro, temi come digitalizzazione delle spedizioni, compliance normativa e sostenibilità spingeranno sempre più aziende a scegliere Incoterms che permettano un controllo maggiore, ma anche una gestione più snella. Perciò, se volete definire la resa più adatta alle vostre esigenze, contattate CTI: possiamo supportarvi nella scelta più efficace per ogni mercato, merce o condizione logistica.